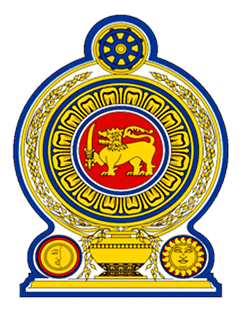Aree sensibili dal punto di vista ambientale: Una storia di conservazione, sviluppo e resilienza

Lo Sri Lanka, pur essendo di piccole dimensioni, fa parte di un hotspot globale della biodiversità a causa della sua ricca biodiversità e delle crescenti minacce dovute all'invasione degli habitat, all'uso insostenibile delle risorse, all'inquinamento e alle specie invasive. Mentre il 28% del Paese è coperto da aree protette (PA), molti ecosistemi critici esistono al di fuori di queste zone. Riconoscendo questo aspetto, il Ministero dell'Ambiente e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), con il finanziamento del GEF, hanno attuato un approccio di cogestione nelle Aree sensibili dal punto di vista ambientale (ESA), paesaggi con un alto valore di biodiversità e servizi ecosistemici al di fuori delle aree protette formali. L'approccio ha coinvolto i settori pubblico e privato, insieme alle comunità locali, per conservare la biodiversità e sostenere i benefici ecologici e socio-economici essenziali per le popolazioni circostanti. Ha promosso pratiche di gestione inclusive e sostenibili, bilanciando la conservazione con un uso responsabile delle risorse e consentendo accordi di collaborazione tra le comunità e il governo. Questo approccio è fondamentale per salvaguardare la biodiversità unica dello Sri Lanka.
Contesto
Sfide affrontate
Le principali sfide che minacciano la biodiversità includono la deforestazione per la coltivazione della chena, l'agricoltura non sostenibile come la monocoltura, l'uso eccessivo di prodotti agrochimici, l'inquinamento e la scarsa consapevolezza del valore della biodiversità. La bassa produttività agricola porta all'invasione delle terre, alla debolezza dei redditi agricoli e turistici a causa delle catene del valore e dell'accesso al mercato, e a problemi sociali come il divario retributivo tra i sessi. L'inadeguata capacità di governance ambientale crea sfiducia tra le comunità e le agenzie governative. Il cambiamento climatico intensifica ulteriormente queste minacce attraverso siccità, inondazioni e temperature estreme più frequenti e severe, accelerando il degrado dei terreni e delle foreste, la scarsità di acqua dolce e la perdita di biodiversità. Questi impatti erodono i servizi ecosistemici e i mezzi di sussistenza tradizionali, soprattutto per i gruppi vulnerabili. Tra le cause principali vi sono il debole coordinamento istituzionale tra i vari settori, la mancanza di una pianificazione sensibile alla biodiversità e l'insufficiente impegno pubblico e politico per la conservazione.
Posizione
Processo
Sintesi del processo
Le tre componenti del processo di sviluppo del Piano di cogestione sono state la valutazione della biodiversità, la valutazione delle minacce e delle tendenze e la pianificazione partecipativa , che erano interconnesse e si rafforzavano a vicenda. La valutazione della biodiversità fornisce le conoscenze ecologiche di base necessarie per capire cosa si vuole proteggere e perché è importante. Partendo da questa base, la valutazione delle minacce e delle tendenze identifica le pressioni che agiscono sulla biodiversità e prevede come queste possano evolvere, assicurando che le decisioni siano informate sia dalle realtà attuali che dai rischi futuri. Questi due livelli, basati su dati concreti, confluiscono direttamente nella pianificazione partecipativa, in cui le comunità e le parti interessate utilizzano i risultati scientifici per elaborare strategie di gestione pratiche e radicate nel territorio. Il processo di pianificazione partecipativa rafforza la titolarità, migliora l'attuabilità delle azioni e garantisce che le misure di conservazione siano socialmente accettabili e allineate con i mezzi di sussistenza. Insieme, queste tre componenti creano un sistema di feedback continuo: la scienza informa la pianificazione, la pianificazione risponde alle minacce e l'impegno della comunità assicura la sostenibilità, producendo infine un Piano di cogestione solido, adattivo ed efficace.
Blocchi di costruzione
Approccio di cogestione
L'approccio collaborativo, in cui le comunità locali e le autorità condividono la responsabilità e il processo decisionale per la gestione delle risorse naturali - come le foreste, la pesca o le ESA - aiuta a bilanciare la conservazione con le esigenze della comunità, a migliorare la conformità, a creare fiducia e a garantire la sostenibilità a lungo termine.
Wewalkele, una delle ESA pilota, ospita diverse specie minacciate, tra cui il Thamba-laya (Labeo lankae), il leopardo, il gatto pescatore, l'elefante e la lontra eurasiatica. Tra le 125 specie di flora, la canna alta e densa (Calamus) cresce in boschetti fangosi e spinosi. I villaggi circostanti raccolgono l'Heen Wewal per l'artigianato, spesso con metodi non sostenibili che integrano il loro reddito.
Riconoscendo il valore della biodiversità di Wewalkele e le minacce emergenti, nel 2018 il Segretariato divisionale e la comunità hanno formato un Comitato di gestione locale (LMC) per sviluppare un piano di cogestione. L'area è stata censita socialmente e delimitata fisicamente per prevenire l'invasione e garantire gli obiettivi di conservazione.
Per non lasciare indietro nessuno, il progetto ha sostenuto le comunità a passare da una raccolta non sostenibile a lavori verdi, migliorando le competenze, rafforzando i collegamenti con il mercato e promuovendo prodotti di canna a valore aggiunto. Sono stati creati vivai di canne e impianti di reimpianto per garantire mezzi di sussistenza a lungo termine. La forte collaborazione tra autorità locali, comunità e LMC ha garantito il successo dell'ESA. Wewalkele dimostra che comunità, habitat e biodiversità possono coesistere e prosperare.
Fattori abilitanti
1. Quadro normativo e politico chiaro
2. Istituzioni e leadership locali forti
3. Fiducia e comunicazione efficace
4. Equa condivisione dei benefici
5. Sviluppo delle capacità
6. Sostegno consistente da parte del governo
7. Gestione e monitoraggio adattivi
Lezione imparata
Una delle lezioni chiave apprese è che l'assenza o la vaghezza di quadri giuridici e politici per la cogestione ha limitato l'efficacia e la sostenibilità degli interventi ESA nella fase iniziale del progetto. Laddove si è formato un sostegno chiaro e riconosciuto, i ruoli delle comunità sono stati più rispettati, i diritti sono stati definiti e i risultati della conservazione sono diventati più duraturi......
L'equa condivisione dei benefici è essenziale per il successo della cogestione delle ESA. Nell'ESA di Wewalkele, gli sforzi di conservazione sono stati progettati per allinearsi con i mezzi di sussistenza locali, in particolare potenziando l'industria artigianale della canna. Grazie alla formazione, ai collegamenti con il mercato e al sostegno istituzionale, le comunità hanno ottenuto redditi stabili, contribuendo attivamente alla conservazione della biodiversità. Questo accordo reciprocamente vantaggioso dimostra che quando le comunità condividono sia le responsabilità che le ricompense della gestione di una ESA, gli sforzi di conservazione diventano più inclusivi, partecipativi e sostenibili.
Risorse
Riscoprire e applicare le conoscenze tradizionali
L'obiettivo è far rivivere, preservare e applicare i sistemi di conoscenza indigeni e locali che storicamente hanno sostenuto l'uso sostenibile e la conservazione della biodiversità all'interno e intorno all'ecosistema della cascata. Questi sistemi di conoscenza sono profondamente radicati in secoli di interazione con gli ecosistemi e offrono metodi pratici e collaudati per gestire le risorse naturali in modo da mantenere l'equilibrio ecologico. Integrando queste conoscenze con la moderna scienza della conservazione, gli sforzi per la biodiversità diventano più rispettosi della cultura, inclusivi ed efficaci. Sri Lanka: I sistemi a cascata di serbatoi (Elangawa) sono antiche pratiche di gestione dell'acqua che supportano la biodiversità acquatica e la coltivazione del riso nelle zone aride.
- Gli anziani dei villaggi e i gestori tradizionali dell'irrigazione (Vel Vidane) sanno quando aprire e chiudere le paratoie in base ai tempi e all'andamento delle piogge monsoniche, non a calendari fissi. Per prendere decisioni sul rilascio dell'acqua si basano su segnali impercettibili come il primo richiamo degli uccelli migratori, la fioritura degli alberi o l'umidità negli strati del suolo: pratiche radicate nell'osservazione, non nei manuali di ingegneria.
- Gli agricoltori mantengono tradizionalmente zone cuscinetto vegetate (Kattakaduwa) sul bordo a valle del serbatoio per filtrare i sali, proteggere la qualità dell'acqua e mantenere la salute del suolo. Questa pratica non era spiegata scientificamente in passato, ma le comunità locali sapevano che la rimozione di queste zone vegetate danneggiava le colture e la qualità dell'acqua.
- Gli agricoltori locali hanno un senso intuitivo di dove si depositano i sedimenti, di come effettuare il dragaggio periodico e di come riutilizzare il limo per migliorare la fertilità del suolo. Queste pratiche hanno contribuito a sostenere i serbatoi per secoli senza modelli idrologici formali.
- Le comunità comprendono la presenza di uccelli, pesci e rettili all'interno e intorno alle vasche come parte della salute dell'ecosistema; alcuni evitano persino di disturbare le aree di nidificazione o di raccogliere il pesce solo dopo il periodo di riproduzione, anche in assenza di regole formali.
Fattori abilitanti
- Memoria comunitaria e continuità d'uso
- Significato culturale e religioso
- Riconoscimento legale e istituzionale
- Convalida scientifica e partnership
- Organizzazioni comunitarie e società di agricoltori
- Sostegno di ONG e donatori
- Riconoscimento globale (ad esempio, status GIAHS)
Lezione imparata
- I progetti che hanno rivitalizzato i sistemi a cascata dei serbatoi hanno avuto più successo quando i ruoli delle società agricole e delle agenzie statali sono stati formalizzati in accordi o sostenuti da politiche locali.
Impatti
Questa soluzione ha creato un ambiente favorevole alla biodiversità senza compromettere lo sviluppo economico sostenibile delle comunità circostanti. Consentendo alle comunità locali e alle parti interessate di progettare e guidare collettivamente gli interventi orientati alla conservazione, ha favorito un forte senso di appartenenza, mentre i benefici economici hanno fornito ulteriori incentivi alla conservazione. L'approccio alla gestione delle Aree sensibili dal punto di vista ambientale (ESA) ha promosso un modello olistico per la conservazione della biodiversità e la pianificazione integrata dell'uso del territorio tra le agenzie governative competenti. Il progetto ha identificato e gestito 23.253 ettari come ESA; ha introdotto pratiche produttive compatibili con la biodiversità su 23.763 ettari; ha integrato 183.957 ettari di aree protette in piani di gestione del paesaggio e del paesaggio marino più ampi. Ha sperimentato modelli di gestione delle ESA su 18.439 ettari di habitat diversi, tra cui foreste, cascate di serbatoi, ecosistemi costieri e colline isolate al di fuori delle aree protette. Ciò ha contribuito a stabilire il quadro di governance necessario per rendere operativa l'ESA e a promuovere una forte collaborazione tra gli stakeholder nei siti pilota di Manawakanda, Kala Oya Riverine, Gangewadiya, Villu e Wewalkale. Sulla base di questi modelli, il Ministero dell'Ambiente ha sviluppato e il Consiglio dei Ministri ha approvato una politica nazionale di ESA per consentire uno sviluppo sostenibile e inclusivo, conservando la biodiversità al di fuori delle aree protette.
Beneficiari
- Comunità locali, coltivatori di risaia e di altre colture, uomini e donne, organizzazioni di agricoltori, imprese agroalimentari locali.
- Agenzie governative locali come il dipartimento forestale, il dipartimento della fauna selvatica, il dipartimento dell'agricoltura e le segreterie divisionali.
Quadro globale sulla biodiversità (GBF)
Obiettivi di sviluppo sostenibile
La storia
Habarawatte, un villaggio alla periferia di Galnewa, nel distretto di Anuradhapura, in Sri Lanka, offre un paesaggio inaspettatamente lussureggiante nonostante sia classificato come zona arida. I campi di risaia color smeraldo, i gruppi di alberi come Mee e Kumbuk e il bacino idrico scintillante del villaggio creano una scena di tranquillità rurale.
Questa serenità è recente. Solo pochi anni fa, Habarawatte soffriva di una grave aridità e gli abitanti del villaggio faticavano a coltivare la terra. La sua trasformazione è il risultato di uno sforzo guidato dalla comunità e sostenuto dal Dipartimento provinciale per l'irrigazione. L'iniziativa ha fatto rivivere un'antica pratica ecologica, il sistema di cisterne a cascata (Ellangawa). Guidato dal Global Environment Facility (GEF), dal Ministero dell'Ambiente e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), il progetto "Enhancing Biodiversity Conservation and Sustenance of Ecosystem Services in Environmentally Sensitive Areas" ha ripristinato il sistema nella divisione GN di Kandulugamuwa, portando un cambiamento visibile nel villaggio.
Habarawatte confina con la foresta e il santuario di Kahalla-Pallekelle, un'area protetta gestita dal Dipartimento forestale e dal Dipartimento per la conservazione della fauna selvatica. I villaggi adiacenti alle aree protette sono fondamentali per la conservazione della biodiversità e l'equilibrio dell'ecosistema. Per questo motivo, Habarawatte è stata identificata come Area sensibile all'ambiente (ESA). L'ESA contiene una biodiversità significativa e fornisce servizi ecosistemici chiave. Il progetto pilota si è concentrato sulla collaborazione con la comunità per ripristinare la cascata di ellangawa, da tempo abbandonata.
La nascita di un campione
Grazie a questa iniziativa, il progetto ESA ha ridato vita a un approccio sostenibile alla pianificazione e alla gestione del territorio che ora consente alla comunità di ottenere benefici economici costanti, proteggendo al contempo un'area vitale e sensibile dal punto di vista ambientale. "Avevamo solo sentito parlare dell'ellangawa degli antichi re, ma non l'avevamo mai vista", racconta Neil Jayawardena, presidente della Habarawatte Farmers Society. "Prima potevamo coltivare solo una volta all'anno, quando arrivavano le piogge, ma dopo il progetto tutto è cambiato".
Prima di essere ristrutturati, i serbatoi abbandonati di Habarawatte facevano parte di un complesso sistema di irrigazione sviluppato dagli antichi cingalesi più di due millenni fa. Il sistema di cisterne-villaggio a cascata, o ellangawa, è una serie di cisterne o serbatoi minori organizzati all'interno di un micro-comparto del paesaggio della zona arida.