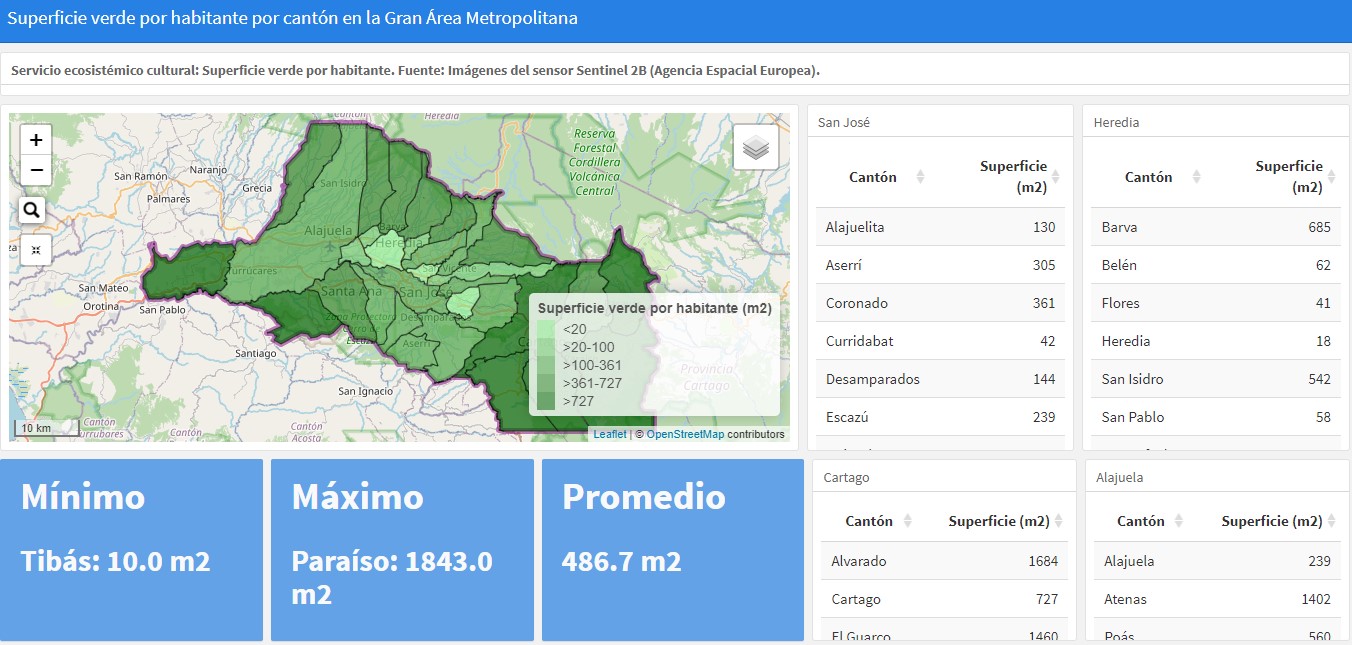La natura dell'interramento di Ercolano 2000 anni fa ha fatto sì che lo scavo a cielo aperto all'inizio del XX secolo abbia rivelato uno straordinario livello di conservazione della città romana, ma ha dovuto essere accompagnato dalla stabilizzazione di queste rovine multipiano e dal ripristino di strade e sistemi di drenaggio. Oggi il sito richiede la conservazione del tessuto archeologico, ma anche di questi interventi di restauro, a scala urbana.
Tuttavia, gli sforzi compiuti a Ercolano alla fine del XX secolo hanno affrontato il sito come una serie di singoli elementi. Ciò era in parte dovuto al limitato accesso a competenze interdisciplinari e a fonti di finanziamento stabili: predominavano sporadici finanziamenti in conto capitale per progetti localizzati una tantum.
Con l'inizio del nuovo millennio, è stato adottato un nuovo approccio che ha mappato i problemi di conservazione e le interdipendenze tra di essi nell'intero sito e ha agito di conseguenza. Gli sforzi iniziali si sono concentrati sulla risoluzione di situazioni in aree a rischio di crollo o con elementi decorativi vulnerabili. Con il tempo l'attenzione si è spostata su strategie a lungo termine per ridurre le cause del degrado e sviluppare cicli di manutenzione dell'intero sito sostenibili solo dall'autorità pubblica, per evitare che il sito torni indietro. Ora che questi interventi sono interamente sostenuti dal partner pubblico, l'obiettivo generale è stato raggiunto.
L'evoluzione del quadro normativo italiano nel 2004 ha permesso al partner privato di appaltare direttamente i lavori di conservazione e di "donare" risultati concreti, anziché limitarsi al sostegno finanziario. Ciò ha permesso al partenariato di costituire un vero e proprio potenziamento operativo del sistema di gestione esistente.
Ulteriori riforme legislative in materia di beni culturali nel periodo 2014-2016 hanno poi rafforzato la flessibilità e la capacità di risposta dei partner pubblici alle esigenze del sito.